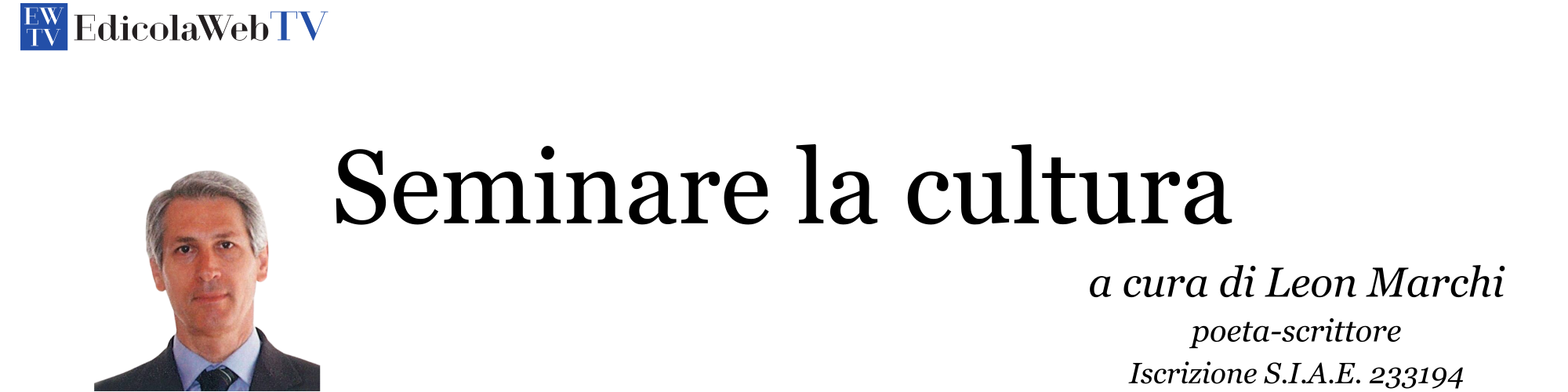Ommini e cani in questo se somijeno
Er sor Checco, seduto su la solita
panchina lungo er vialetto, godennose
er calore der sole, guarda e penza:
«Nun è vero che ar monno ce sia solo
dolore, e fame, e guera. Se sa, l’omo,
pe’ vizzio, sempre se lamenta, e tutto,
e tutto vede nero, anche la luce».
E propio in quer preciso momento, ecco,
l’uno de dietro a l’antro, passà du’
cani ar guinzajo. «Er padrone,» commenta
er sor Checco, «somija ar cane… Inzomma,
aripijanno er filo der discorso,
er cane ch’è davanti tira e smania,
ch’a momenti se strangola e dà l’anima;
l’antro, ar contrario, ormai vecchio, er padrone
lo deve da tirà e, si s’accuccia,
lo deve da convince co’ le bone
perché, poretto, nun è pe’ cattiva
volontà, propio, propio nun je la fa.»
Un soffio de vento dispettoso e rude
er calore je caccia da la pelle
e je fa sentì freddo; così er sor
Checco s’arza e, cór core in gola, dice:
«Ommini e cani in questo se somijeno:
tireno e smanieno, quanno so’ gioveni;
ma da vecchi, da vecchi come me…
ce vô poco a capillo… vanno piano,
fermannose ogni tanto, cór soriso
su le labbra, pe’ mannà giù l’amaro
che sta ‘n fonno a ‘sta vita… benedetta.»
Uno stretto parente tuo
Un ragno, doppo la fatica grossa
de filà giorno e notte la ragnatela
per sé medesimo e la famijola,
inzomma, doppo la grossa fatica,
a dondolo su un filo, se godeva
un meritato attimo de riposo, quanno
a l’improviso uno che nun ciaveva
gnissun rispetto de l’antri attorno,
co’ la mano la fonte je distrusse
der pane quotidiano. Giù, de córpo,
da quell’artezza, gridò ar deficente:
«Ma chi sei? come te permetti, tu,
omo da du’ sordi, de creamme un
danno così grande?» E l’antro, con tono
strafottente, più pronto de ‘n cortello
lanciato ar circo, arispose: «Chi sono?
Me dovressi da riconosce: so’
uno stretto parente tuo.» Sorpreso
da le parole intorcinate e buie,
er ragno, zitto e muto, prese tempo,
facenno l’artalena fino ar naso
de quer coso, quanno se rese conto
che, pe’ fortuna, nun je somijava
nemmanco un poco. Allora, con parole
diritte e chiare, j’arispose: «Bello
mio, tu somiji… a quelli come te!»
E quello: «Nun te fa onore fa’ finta
de nun esse parente mio. Siccome
ciò un po’ de tempo, me pare senzato
e giusto portà luce ar furminato
cervello tuo. Inzomma, pe’ falla corta,
dico che tutto te somijo drento
ar midollo.» «E, de fora, te somijo?»
lo punzecchiò er ragno. E quello: «Mio caro,
de fora semo diversi, perché
tu sei ragno e io so’ omo, pe’ superiore
decreto. Drento, ‘nvece, in der midollo,
ciavemo er dono de filà le mejo
ragnatele.» «Le mejo…?!» esclamò er ragno.
«Tu da ragno, perché sei ragno; io da omo,
perché omo sono,» arispose ‘mpettito
l’antro. «Er prodotto mio se vede; invece,
er tuo?» serafico continuò er ragno.
Stizzito un po’, disse l’antro: «Er mio, caro
te, nun se vede ma produce effetto
eguale a quello tuo.» «Attiri e divori?”
er ragno domandò. «Attiro e divoro,»
arispose l’antro, arterato; «tu,
però, nun sei più bravo, ma sortanto
più servaggina ciai a disposizzione.»
E tajò corto, senza finì ‘ntero
er discorso: co’ la mano vijacco
mollò er córpo sur povero ragno,
che, còrto ‘n pieno, accoppato morì.
Ma poi me scordo
Quanno me ‘ncontra, ogni vorta domanna:
«Mo ‘ndo vai, mo che fai?», co’ quer soriso
su quelle labbra guasi prosciugate.
E mentre j’arisponno, come er gatto
fisso me guarda che gnente da giorni
magna, nemmanco, nemmanco un sorcetto.
Doppo dieci minuti o quindeci,
ancora tira fori antre domande
e antre, a raffica, però sotto forma
de parere, perché io de sicuro
so’ più ‘nformato e più ne so de lui.
A la fine, siccome cià da fa’,
doppo mezz’ora o quaranta minuti,
bello bello me saluta e me lascia
co’ la testa pesante e un gran malessere.
Sì, de scanzallo già, già ciò penzato;
ma poi me scordo, poi, de cambià strada.
L’ucelletto e l’arbero
«Amico mio, te devo di’ ‘na cosa
che ciò, ciò qui, su la punta der becco:
“Me dispiace che sei, che sei, da guasi,
da guasi ‘n anno moscio e rinsecchito,
come si tu fussi malato o peggio,”
cinguettò l’ucelletto, giù sartando
sur ramo più basso. L’arbero, zitto
quarche minuto, a la fine aripose,
co’ ‘n fil de voce: «Ho tera e sole, e sto
in posizzione invidiabbile, senza
gnissuno attorno, ma so’, so’, purtroppo,
er pisciatoio de quei cani ch’escheno,
che da quer portone escheno, poracci,
co’ la vescica gonfia, ch’a momenti
je scoppia, tanto da fa’, da fa’ pena.
E dopo, dopo che se so’ svotati,
li vedo córe felici, mentr’io
me sento dar veleno morde er fegheto.»
«Capisco,» disse l’ucelletto, via
cor còre triste volanno lontano,
dove er penziero finì tra de sé:
“Amico mio, ma la corpa nun è
dei cani, che nei campi la farebbero
com’è ne la natura loro, mai
tutta ‘nsieme, ma un po’ pe’ vorta, a schizzi:
la corpa è de quei cani… de’ padroni.”
Mo vojo dormì
Mo, dopo ‘n’antra giornata de sgobbo,
magno, nemmanco vedo ‘a Roma mia
e, stanco morto, me butto sur letto.
E da poco me so’ addormito, quanno,
a tradimento, ‘a vijacca, ronzanno,
nun se decide s’atterà sur braccio
o su artra zona de la pelle mia.
Mo pare de gradì ‘na coscia, mo,
volanno più su, prima er collo e poi
er lobbo de ‘n orecchio. «Basta!» penso
e dico ‘ncora co l’occhi là chiusi,
sotto a le parpebre che ‘n po’ cominceno
a movese, sentito avenno quer
volo, quer volo loffio. Me domanno:
m’arzo o m’arenno a la vampira? L’occhi
opro de botto e m’arzo. Più nun sento
‘a vijacca: da quarche parte mo,
mo s’è niscosta. Accenno er lampadario,
e l’occhi appizzo, tutt’e due, su i muri:
gnente de lato, gnente de fronte… ecchila
là, bona, un parmo sortanto dar quadro
sopra ‘r letto. Me vola via, si mo
p’accoppalla nun trovo quarche cosa,
in fretta, sinnò scappa. Penso subbito
a ‘na pantofola… mejo lo straccio
de la porvere… mejo, più vecina,
er panno là ‘n cucina. Detto e fatto:
l’arma strignenno forte ne la mano,
so’ pronto ad accoppà quela vijacca.
Ma ‘ndove, ‘ndove s’è niscosta? Più,
più nu’ la vedo… No, là, là, m’aspetta,
me sfida. Entrambi, entrambi vonno, er panno
e la mano, partì… Je dico: «State
boni: pensamo ar modo d’accoppalla,
ar primo corpo, sinnò la vijacca,
addio, ce vola via». Via m’è scattata
la mano, in quer momento decidenno,
o la va o la spacca. Guasi guasi,
guardannome la mano, nun ce credo:
l’ho fatta secca; nun j’ho dato er tempo…
Ecchilà là, ‘na… ‘na macchia de sangue
sur muro! Mo, però, mo me dispiace
de nun avè, de nun avè comprato
da li cinesi la rachetta elettrica:
co ‘na scossa, mo er muro nun ciavrebbe
quela sporcizia, che poco me piace
e devo toje domattina… Mo,
davero ciò sonno: vojo dormì.
Una regazzina
Seduto ar bare, bevenno er caffè
piano, a sorsi, ‘na regazzina là,
a venti metri, vedo ballà, sola,
sur marciapiede, come drento, drento
a ‘n gran teatro, cor pubbrico attento
e immobbile, che guasi nun respira.
Una rondine me pare o ‘n pesce o ‘na
foja che lentamente cade o un soffio
de vento. Er core tutto s’emozziona,
tanto che chiudo l’occhi; e, quanno li opro,
la regazzina non c’è più: sparita.
No, compare de novo, e a destra guarda
e a sinistra, e me dedica un inchino.
M’aveva forse o certamente visto
la cinesina? Sì, perché dopo ‘n po’,
passanno co’ la madre parrucchiera,
e uscenno poi dar bare cor gelato
in mano, fisso me guarda e soride.
Là, davanti ar negozio de la madre,
mo, mo, leccanno er gelato, me guarda.
Tutti dicheno
All’arberi pizzuti se n’è annato
dopo ‘na vita ‘ntera avé sgobbato,
lassanno sòrdi e case, a moje e fiji.
Tutti dicheno ch’è stato un brav’omo;
ma si allora, si allora un disgrazziato
fosse stato magnannose co’ machine
e donne tutto quanto, un fiore, mo’,
un fiore ce l’avrebbe sulla tomba:
de quarche disgrazziata come lui.
Er ruffiano-segugio
Er ruffiano-segugio,
che annusa puro lo scarico
der culo,
guadambiannose er pane
e la cariera,
disse ‘n ber giorno ar compare,
che propio nun se dava pace:
«Amico mio,
p’avé successo a ‘sto monno,
p’avé successo,
leccà nun basta,
ce vò antro,
sì, ce vò antro.
Io… come,
come ce so’ riuscito?
È semprice,
come ce so’ riuscito:
io… io so’ stato furbo,
ciò visto,
ho scerto er culo giusto».